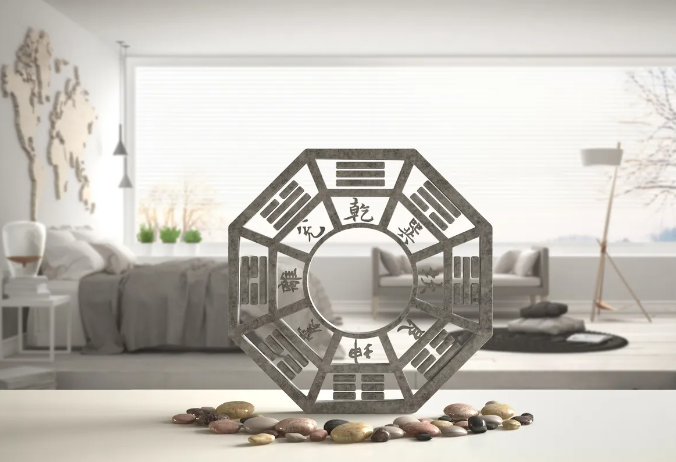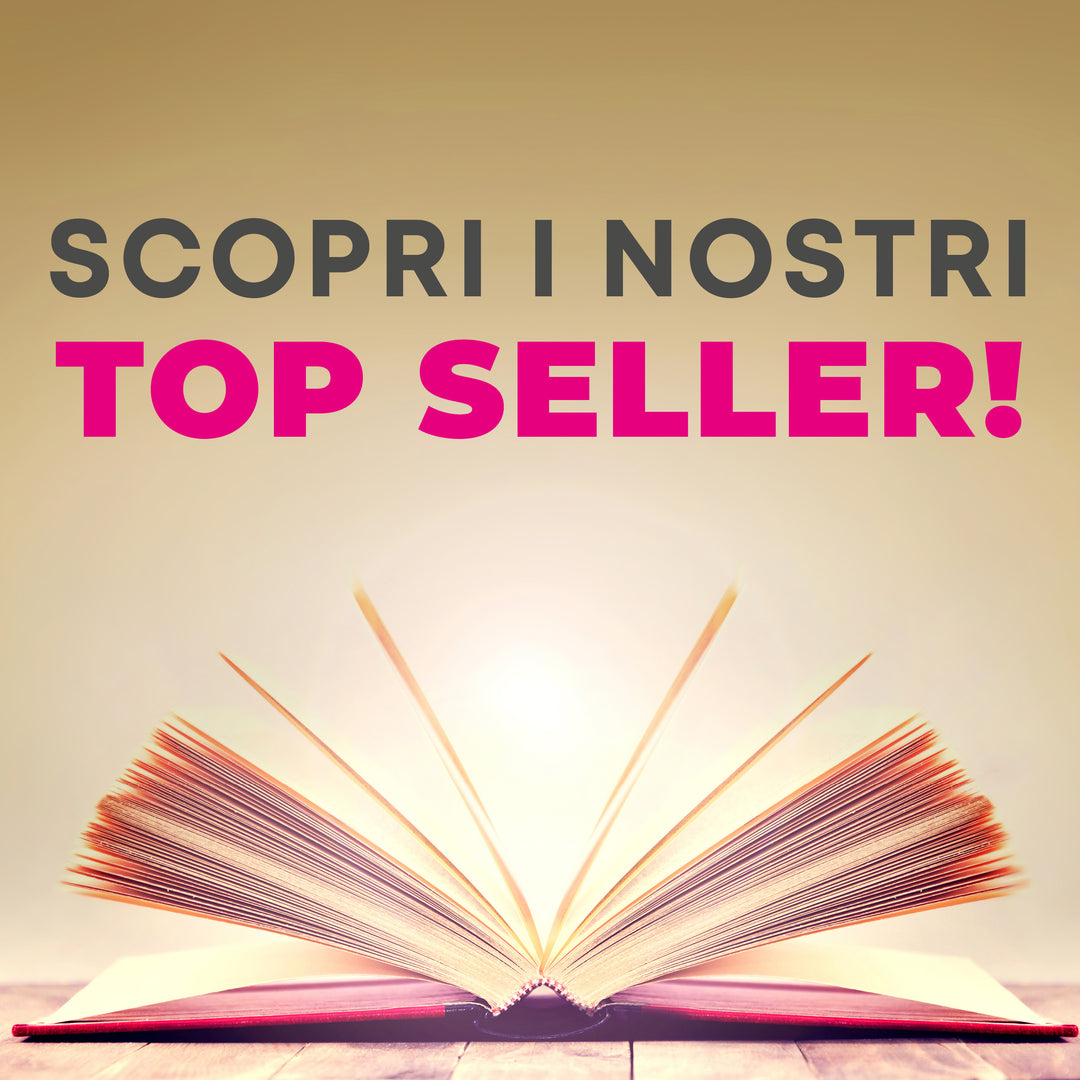Laureata in Scienze Biologiche ed in Psicologia, specializzata in Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico con formazione analitica junghiana; vice-direttore scientifico e docente presso la Scuola di Psicoterapia ANEB di Milano, docente presso la Scuola di Psicoterapia Aiòn di Bologna e presso la Scuola di Naturopatia del Centro Natura di Bologna. La dott.ssa Maria Pusceddu ci regala un breve saggio introduttivo al sogno nelle sue componenti biologico-psichico-spirituale.
Scrivere un articolo sul sogno è un’impresa ardua. Sembrerebbe un argomento semplice: su questo tema sono stati scritti fiumi d’inchiostro ed in fondo si tratta di un fenomeno molto studiato che si verifica in ciascuno di noi ogni notte. Eppure esso è per sua natura evanescente ed inafferrabile, tanto da sfuggire ad una precisa definizione sia dal punto di vista scientifico sia psicologico.
Cercherò di fissare alcuni punti su cui possa aprirsi una riflessione da parte dei lettori partendo dai dati scientificamente certi. Studiando il funzionamento del cervello attraverso l’elettroencefalogramma (EEG) durante il sonno si evidenziano fasi diverse; possiamo riassumerle in quattro fasi di onde cerebrali più o meno lente e sincronizzate ed una fase di onde veloci e desincronizzate, simili a quelle dello stato di veglia. Svegliando il soggetto durante questo periodo di sonno desincronizzato, egli riferisce che stava sognando.
Questa fase del sonno è caratterizzata a livello fisico da una particolare atonia muscolare che impedisce l’attività motoria; fanno eccezione i muscoli degli occhi, che si muovono sotto le palpebre chiuse come se seguissero delle immagini visive. Per questa particolarità, il periodo del sonno in cui si sogna si definisce fase REM (Rapid Eyes Moviments). Nel corso del sonno si alternano fasi a onde lente e fasi REM; queste ultime diventano più frequenti verso il mattino. In totale, ogni notte un soggetto adulto passa circa il 25% delle ore di sonno a sognare. I neonati sognano molto più di noi: circa il 50% delle ore di sonno. Il feto sogna ancora di più; infatti i prematuri nati di 8-8,5 mesi hanno un 60-65% di fase REM, mentre i settimini un 80%. Man mano che il bambino cresce la fase REM diminuisce per attestarsi alla pubertà sui valori dell’adulto.
Da questi dati possiamo desumere che il sogno sia un’attività psichica che prepara alla vita, attivando mentalmente schemi comportamentali che non possono essere realmente esercitati durante la vita intrauterina o nella prima infanzia. L’attività del sogno compare dunque prima di quella reale, come l’immaginazione precede l’azione. Quindi, la capacità immaginativa che ci rende uomini nasce dai sogni. Shakespeare diceva che “siamo fatti della materia dei nostri sogni”; non era lontano dal vero!
E gli animali sognano? Gli studi dimostrano che i Rettili hanno il sonno a onde lente, ma non la fase REM; quindi presumibilmente non sognano. Gli Uccelli e i Mammiferi, derivati entrambi per evoluzione dai Rettili, hanno un metabolismo energetico più elevato (omeotermi) ed un cervello più grande e complesso. Essi presentano la fase REM, più limitata negli Uccelli e più sviluppata nei Mammiferi: tra questi è minore negli erbivori e maggiore nei carnivori. Gli esperimenti dimostrano che essi nel sogno agiscono l’esplorazione, l’attacco predatorio, il combattimento, ecc. Così gli animali più evoluti, in cui molti schemi di comportamento non sono innati bensì appresi, hanno bisogno di simulare in sogno certe situazioni, per essere pronti ad affrontarle nella realtà.
La simulazione (cioè il “come se”) è quindi necessaria al pieno sviluppo del potenziale psichico, è la condizione imprescindibile per l’evoluzione verso il pensiero astratto, la possibilità d’immaginare e lo sviluppo della simbolizzazione.
L’importanza del sogno può essere valutata anche in base alla quota energetica che richiede: in fase REM il cervello consuma più ossigeno che durante un intenso esercizio fisico o mentale da svegli. Dato che la Natura è buona amministratrice dell’energia, è evidente in tutto ciò un vantaggio selettivo e quindi evolutivo.
Ma al di là dei dati scientifici, che cosa rappresenta il sogno per la psiche umana? Presso i popoli antichi i sogni furono sempre tenuti in grande considerazione come anticipatori di eventi o come veicoli di comunicazione tra il divino e l’umano. L’oniromanzia, cioè la divinazione attraverso i sogni, era praticata ovunque. Ricordiamo, per esempio, i sogni di Giuseppe che indicarono al Faraone il modo di salvarsi dalla carestia che avrebbe colpito l’Egitto. Nell’antica Grecia, nei luoghi di cura annessi ai templi del dio Esculapio, i pazienti venivano messi a dormire in particolari stanze con il soffitto a volta (come l’utero) ed erano indotti a sognare, anche con l’aiuto di particolari erbe; Esculapio stesso avrebbe dato, attraverso i sogni, l’indicazione della terapia per il loro male. Gli esempi sarebbero migliaia da ogni angolo della Terra. Solo la civiltà occidentale, malata di meccanicismo e di “scientismo”, ha negato importanza, valore e significato a questo fenomeno così fondamentale per la nostra vita; tanto che, se viene sperimentalmente interrotto il sonno REM una notte, il soggetto lo recupera la notte successiva.
Abbiamo dovuto aspettare i primi del ‘900 affinché, grazie a Sigmund Freud, ci fosse una riscoperta del valore del sogno. Freud affermò che la psiche umana è formata da una parte cosciente, l’Io, e da una parte inconscia, specificando che la seconda è molto più vasta della prima. Egli sosteneva che l’inconscio contiene gli istinti (Es), le norme sociali introiettate (Super-Io) e tutto ciò che della nostra esperienza non viene accettato e pertanto cacciato fuori dal livello di coscienza (il rimosso). I sogni, secondo Freud, sono l’appagamento di desideri inconsci che si ripresentano alla coscienza in forma mascherata; da qui la distinzione tra il contenuto manifesto del sogno ed il contenuto latente. La psicoanalisi, svelando attraverso l’interpretazione il contenuto latente dei sogni, poteva aiutare il soggetto a prendere coscienza del rimosso ed a liberarsi della sua nevrosi.
Carl Gustav Jung ampliò enormemente il concetto d’inconscio e, con esso, il valore attribuito al sogno. Egli, studiando la mitologia comparata di tanti popoli lontani tra loro nel tempo e nello spazio, si accorse che vi erano temi simbolici comuni a tutti; a questi elementi fondamentali, strutturanti la psiche di ogni uomo, diede il nome di archetipi.
Jung comprese che l’inconscio non era soltanto un aspetto personale, legato al singolo individuo, ma qualcosa di molto più vasto, contenente anche vestigia dell’evoluzione psichica della specie umana; egli pertanto ipotizzò che l’inconscio personale altro non fosse che un aspetto più superficiale di qualcosa di molto più profondo: l’inconscio collettivo.
Secondo l’ottica junghiana, i sogni quindi non sarebbero soltanto “emergenze” di un nostro rimosso individuale, ma anche messaggi che arrivano da un enorme serbatoio di sapienza antica che riguarda l’evoluzione psico-biologica dell’intera umanità. Il sogno è un mondo in cui vengono trascese le leggi legate alla materia: non ci sono vincoli di spazio o di tempo: si può essere attori e spettatori di una stessa scena, si può essere presenti in forma di bambino e di adulto contemporaneamente, ci si può trasformare in un’altra persona, in un animale, in una pianta, ecc., ci si può ritrovare nel passato o fare una sortita nel futuro (sogni premonitori), si possono attivare simboli potenti che c’indirizzano in una scelta o in un cammino da seguire. Il sogno è un mondo “altro” eppure profondamente nostro, a cui si accede misteriosamente in una fase del sonno in cui il corpo fisico viene immobilizzato e da cui è più difficile essere svegliati rispetto ad altre fasi del sonno; infatti, a dispetto del tracciato EEG simile a quello della veglia, la fase REM è quella del sonno più profondo, quella in cui noi siamo “altrove”. Ma il sogno parla per simboli che vanno decifrati. La maggior parte di noi ha perso questa capacità; così un patrimonio nostro va perduto.
Soltanto se una sofferenza, spesso inspiegabile, ci porta in psicoterapia analitica scopriamo la possibilità di riaprire uno scrigno dimenticato, pieno di cose preziose che ci appartengono. Accompagnati dall’analista, che conosce la strada per averla già percorsa, ci addentriamo in un mondo fantastico ove tutto è possibile, ove s’incontrano demoni e dei, streghe e maghi, paura e gioia. È una discesa agl’Inferi per ricevere, come Ulisse, Enea, Gilgamesh o Dante, una risposta dalle ombre che sanno, per poi “tornare a riveder le stelle”.
Attraverso i messaggi dei sogni, l’energia ingorgata nei complessi inconsci torna disponibile per dare un nuovo impulso alla nostra vita. Il sogno, una volta compreso, è il più importante transduttore di energia dalle profondità dell’inconscio alla coscienza attiva; è monito, guida alla conoscenza, il mezzo per sentir vibrare in noi la storia evolutiva che ci ha generati e per sentirsi, insieme alle altre creature, una parte del Tutto. Del resto, il grande Eraclito diceva: “Gli uomini nel sonno lavorano e collaborano agli avvenimenti dell’Universo”. Ciò che per gli antichi era ovvio, per noi è dunque una dimensione fondamentale da riconquistare.
di Dott.ssa Maria Pusceddu