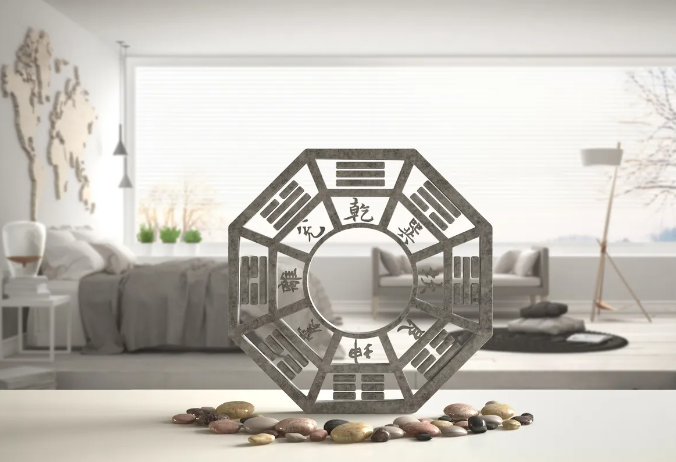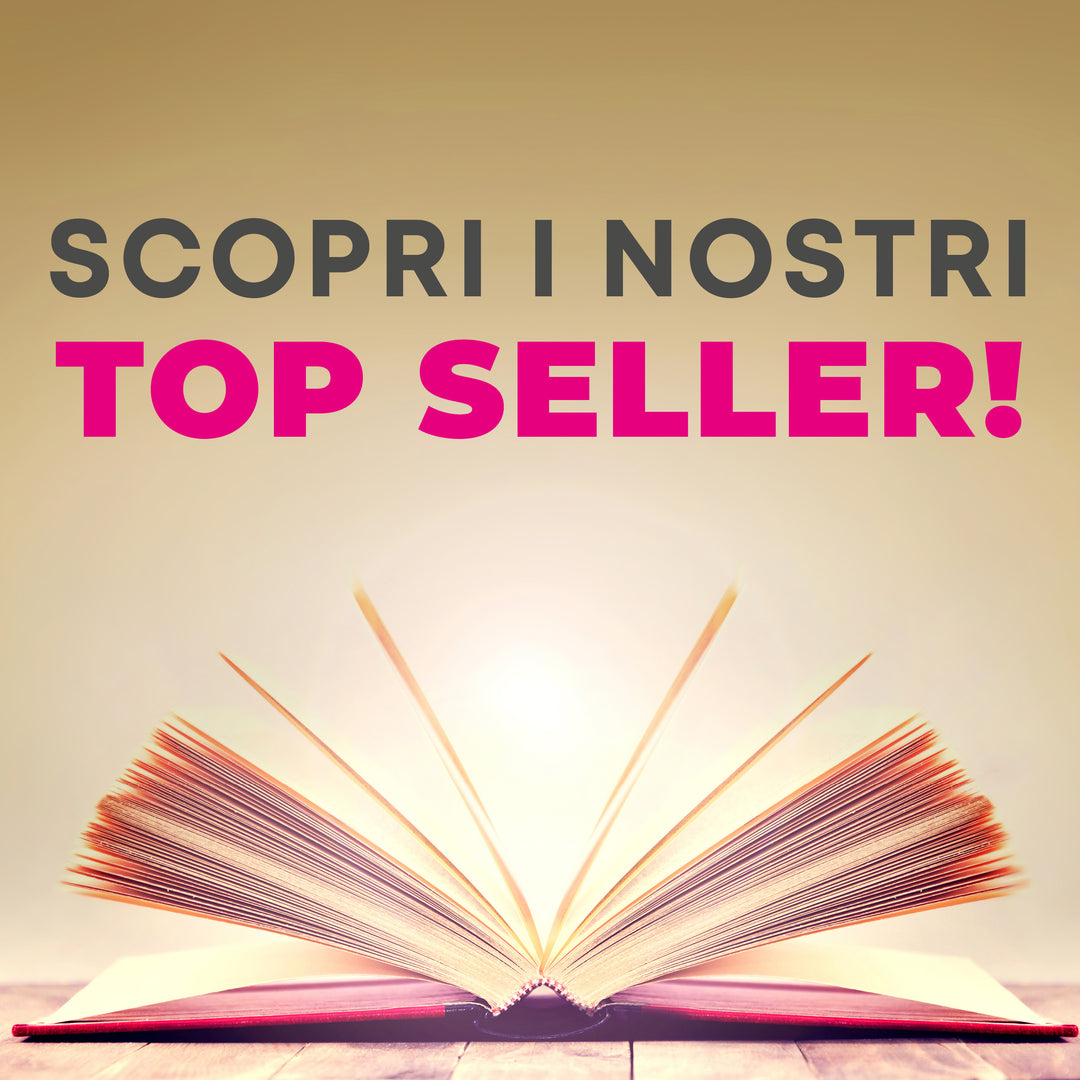Arjuna disse: «Mio caro Krishna, vorrei sapere che cosa sono la natura e la persona, che cosa sono il campo e il conoscitore del campo, la conoscenza e l'oggetto della conoscenza.»
Bhagavad-gita capitolo 13 versi 1-2
Ogni volta che squadriamo un foglio, o tracciamo un cerchio con il compasso o la matita, oppure apriamo le braccia sconsolati, stiamo indicando il mondo.
Nel caso del disegno tentiamo - consapevoli o meno - di ridurre il mondo a spazio. Quest’ultimo, per dirla con Albert Einstein, andrebbe più precisamente chiamato spazio-tempo.
Il mondo non più luogo, dunque, ma mera distanza spaziale. Luogo e spazio non sono sinonimi. L’equivoco tra i due conduce ad un vincolo, ad una gabbia fin troppo stretta. Forse mai come oggi tutta da ripensare, da mettere in discussione. Poco cambia se la carta è stata soppiantata dallo schermo di uno smartphone - basti pensare all’eccezionale diffusione delle mappe digitali, segno che siamo diventati sempre più «consumatori» della geografia.
Ma ci siamo misurati con il misurabile, e con esso fin troppo identificati.
I saggi di Oriente e Occidente, anche ai tempi degli antichi greci, lo sapevano bene. Con la summenzionata domanda di Arjuna risalente ad un dialogo antico 52 secoli inizia ciò che in seguito verrà chiamato «discorso geografico», da cui prende le mosse l’intera filosofia. Lo storico Strabone fu chiarissimo in merito: la prima forma di pensiero occidentale si chiamava geografia, la stessa che nelle scuole abbiamo imparato come filosofia presocratica e si è soliti definire «sapienza greca», laddove uno dei primi crucci dei pensatori era misurare il mondo conosciuto.
Immanuel Kant scriveva di filosofia ma insegnò geografia per quarant’anni. Egli stesso indica la svolta decisiva del suo pensiero dalla geografia di quel che si vede, alla geografia dello «spazio buio della nostra mente».
In queste pagine parleremo, senza usare troppe mappe, di geografia. Poiché da lì è iniziato l’equivoco tra campo e conoscitore del campo, così come tra spazio e luogo, portando con sé concezioni fuorvianti. Parleremo soprattutto d’identità; spesso e volentieri partendo dall’attualità, poiché la geografia, almeno nelle intenzioni degli antichi, non è solo rappresentazione, raffigurazione dello spazio o del campo. Dallo spazio cartografico, metrico lineare, possiamo tentare di evadere. E magari, chissà, ritrovare il nostro vero volto.